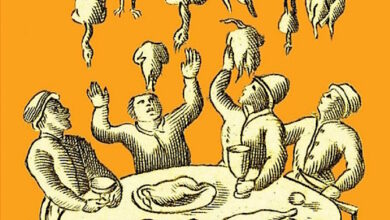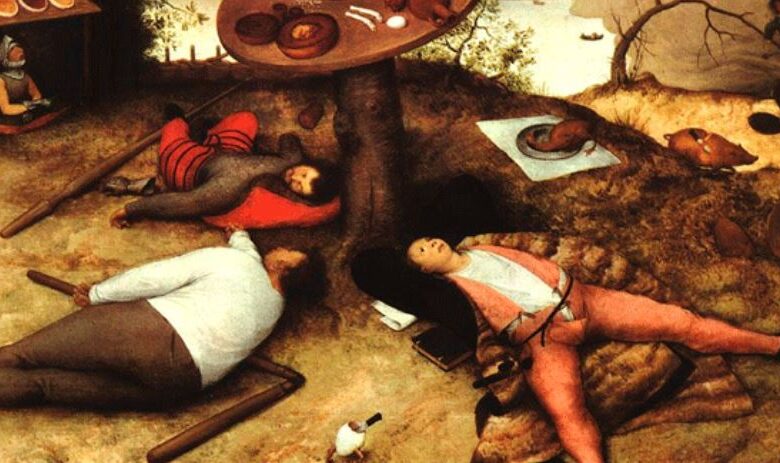
Il lessico culinario nelle canzoni piemontesi di Padre Ignazio Isler (quarta parte)
Canzone XLV(Pentimento fratesco; 1762?): vv. 41-55 e 76-85
Due canzoni isleriane (la XLV e la XLIII) trattano un argomento similare: i lamenti di un frate e quelli di una monaca che si pentono della loro scelta, lamentandosi della loro misera condizione. Nella canzone che ha come protagonista il frate alcune strofe sono dedicate all’alimentazione, sottolineando come in convento si mangi male sotto tutti gli aspetti. Alla strofa 9a il protagonista, un giovane, da poco entrato in convento non certo per vocazione convinta, ma piuttosto con la speranza di vivere nella tranquillità e nell’abbondanza, si lamenta tra le altre cose del vitto del convento, presentandoci un’immagine icastica: Se si potesse guardare nella pancia di un frate, cosa si vedrebbe? Risposta: un giardino coltivato, con rave, sicòria, d’andivie e spinass,/ card e caròte, cossòt, ramolass,/ laitùe, seleri e còj carpionà (rape, cicoria, indivia e spinaci; cardi e carote, zucchini, ramolaccio, lattughe, sedani e cavoli inaciditi); solo verdure, quindi, ma anche il vino non è soddisfacente, in quanto l’é d’ordinari tut vin avansà,/ àiri, puntos e picërla rablà,/ l’é bon miraco s’a l’é nen bodrà: è dunque, normalmente, tutto vino d’avanzo, inacidito, puntoso (di sapore sgradevole, cioè con una “punta” di sapore non buono) e annacquato (picërla rablà: tautologia, in effetti già la picërla di per sé significa “vinello annacquato”, o meglio aqua passà ’n sla rapa, cioè acqua fatta solamente passare sulla raspa per insaporirla di vino e nulla più, in aggiunta rablà vale “trascinata, allungata”), anzi è un miracolo se non è anche “mescolato”, nuovamente con acqua. Si passa poi a raccontare del pane, col pan ch’a l’é drinta al pané,/ fàit con d’arprim e mëstura, e grossé;/ ch’a digerilo j’é tuti ij da-fé;/ l’é giàun e vard e turchin e marbrà, quel pane che sta nel deposito, fatto di cruschello e di mescolanza (di frumento con cereali di peggior qualità), e grossolano, a tal punto che per digerirlo ci va del bello e del buono; è giallo e verde e turchino e screziato di vari colori. Verdure, vino e pane, ma anche il cuoco, quanto ad incapacità, non scherza. Quand i pensomo arivé a un bon disné,/ òh che cagnin-a con col cusiné!/ A sà fé nen mach dle torte salà,/ brusche, aramìe e pì ’d mese brusà,/ con una mnestra bin mal tapassià. Quando pensiamo che si arrivi ad un buon pranzo, ahi che rabbia con quel cuoco! Non sa fare altro se non torte salate, acide, che sanno di pentola bruciata e più che mezze bruciacchiate, con una minestra pasticciata (letteralmente “male in arnese”; ardita quindi la metafora, che vede la minestra come una persona, mal ridotta). Sempre il cuoco è uno che Ij seu potagi pì bon ch’a sà fé,/ a l’é quàich vòta ch’a fà fricassé/ e tripe e fìdich e carn avansà,/ subrich e barb e fricon spotrignà,/ cosse, marsan-e e spinass afumà: le migliori pietanze che sa fare sono, talvolta, far friggere trippe e fegato e carne avanzata, frittelle (in genere di verdure o di carne, o di tutt’e due insieme) e barbi e sardelle spappolate (cioè troppo cotte), zucche, melanzane e spinaci lessi.
Canzone LV (Sesso feminino Poema detto volgarmente Tòni; senza data): vv. 471-490 e 511-530
Il Poeta, secondo una tradizione ampiamente diffusa nella poesia (specie quella popolare), fa un lungo elenco dei vari tipi di donne, e dei loro difetti, e delle situazioni più o meno comiche e satiriche in cui le donne sono coinvolte; giunto ad esaminare le caratteristiche delle donne in gravidanza (vv. 451-530), egli si diffonde ad elencare e commentare tutte le varie “voglie” delle donne incinte, tra cui, in materia di cibo, ci si sofferma sui vari cibi di cui esse sono vogliose.
Abbiamo (vv. 471-480) una sfilza di richieste che le donne gravide fanno ai loro mariti: Ch’a van ciamand dle geladin-e;/ d’àitre peui l’han d’àitre anvìe,/ van sercand torte candìe,/ dle përnis e dle bëcasse,/ tord, fasan e torde grasse./ Òh le bele galupasse!/ A-i n’é ch’a veulo ’d colombòt,/ dij polastrin e bon dindòt;/ d’àitre han veuja dij mërlan,/ dle trute, anguile sensa pan: chiedono delle gelatine, mentre altre, che hanno altre voglie (anvìe), cercano torte candite e uccelli selvatici (in piemontese: volaja): pernici e beccacce, tordi (notiamo comunque che la forma più genuinamente piemontese per il tordo è griva), fagiani e tordi femmine grasse; davvero delle gran ghiottone (galupasse), quelle che vogliono uccelli da cortile (polaja): piccioncini, pollastrelli, e tacchini piccoli, ma buoni; altre, a loro volta, chiedono pesci: naselli, trote, anguille senza pane.
Seguono (vv. 481-486) Dle trìfole ant le fondùe:/ guardé ampòch s’a son golùe!/ Na mangg-rìa ’dcò mi un gavi,/ con tut lò ch’i sia pa gravi./ ’Dcò mi mangg-rìa un biribin/ sensa sërché ’d mangé ’d sufrin. Tartufi nelle fondute; vedete quanto sono davvero ghiotte, e dire che di queste leccornie ne mangerebbe una scodella grande (gavi) anche il poeta (che pure non è gravido); così come si mangerebbe pure lui un tacchino (biribin vale il dindòt di prima) senza neppure andar cercando le frittelle (sufrin è forma alternativa per subrich).
Infine, si fanno ancora portare delle miche mòle (v. 513: pagnotte morbide) oppure (vv. 516-520) le soe supëtte/coste bele galupëtte,/ o una tassa ’d ciocolata/ch’al sò stòmi serv d’opiata/ con un grissin ’d pan bëscotà: le loro minestrine (queste sono davvero delle ghiottoncelle) o una tazza di cioccolata, tale che per il loro stomaco vale come una prima colazione (opiata è un antico termine farmaceutico) con un filoncino (attenzione: grissin non è il nostro “grissino”, ma una piccola ghërsa, cioè una sorta di “sfilatino”) di pane biscottato.
Si finisce, dopo che già a l’han tafià (cioè “mangiato a quattro palmenti”), con quàich bëscotin giassà, con qualche biscottino glassato.
Dario Pasero
Per consultare la prima parte cliccare QUI
Per consultare la seconda parte cliccare QUI
Per consultare la terza parte cliccare QUI