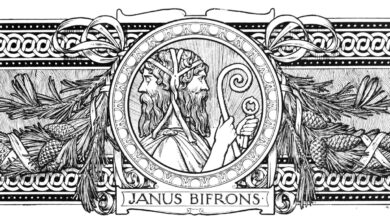Modi di dire della Lingua piemontese: “Avèj la coa ‘d paja” (avere la coda di paglia)
Una tra le più diffuse locuzioni verbali della Lingua piemontese è sicuramente questa: “Avèj la coa ’d paja”, ovvero: “Avere la coda di paglia”. Se in una qualsivoglia località del Piemonte si intervistasse a caso un campione di persone nate e residenti da tempo sul posto, ebbene, probabilmente quasi tutte risponderebbero correttamente in merito al significato di questo modo di dire. Avèj la coa ’d paja, si sa, significa essere sempre sul chi va là, sempre pronti cioè a reagire o a difendersi ancor prima che un’accusa (più o meno giustamente) ci venga rivolta. Una sorta di stato di pre-allarme costante, di allerta continua, che induce a scattare bruscamente alla prima (reale o presunta) provocazione, in un abuso, potremmo dire, di legittima difesa. Questo atteggiamento può essere frutto di una patologica mania di persecuzione, ma potrebbe anche essere provocato da un effettivo stalking, che tende ad esasperare le reazioni del malcapitato, vessato da reiterate e insistenti esperienze negative.
Comunque sia, sta di fatto che “una coda di paglia” tende ad accendersi ed incendiarsi con una certa facilità. È in questo principio fisico che sta il reale senso di questa curiosa espressione popolare.
Forse però non tutti ne conoscono la genesi.
È evidente che si tratta di un’espressione metaforica: in effetti nessun animale, a due o quattro zampe, nasce in Natura con la coda di paglia. Gli unici a disporne, tuttalpiù, sono quelli uccelli o quei quadrupedi che sono stati impagliati post mortem.
E allora? Per risolvere il busillis ci può aiutare un vecchio proverbio piemontese che prende l’abbrivio proprio da questo modo di dire: “Chi a l’ha la coa ’d paja, a l’ha sempre pàu che a-j ciapa feu ’l darera” (Chi ha la coda di paglia ha sempre paura che gli si bruci il di dietro).
Nulla di più vero. Lo sapevano bene, nel Medioevo, quei delinquenti e imbroglioni che venivano condannati alla gogna, e ai quali pare venisse applicata sul posteriore una coda di paglia. I concittadini potevano dare fuoco alla prominenza posticcia del condannato (che fungeva da miccia) in gesto di scherno e umiliazione, causandogli pena e dolore, e mettendo a duro rischio la sua vita.

Secondo un’altra interpretazione, la locuzione verbale deriverebbe da una favola attribuita ad Esopo, in cui si racconta di una volpe che, rimasta con la coda pizzicata in una tagliola, per quanto fosse riuscita a salvarsi la vita, in quella trappola perse definitivamente la sua coda. La volpe cadde in depressione per aver perso quella che per ogni volpe è motivo di ambizione e di eleganza.
Gli altri animali selvatici decisero di fabbricargliene una di paglia e gliela applicarono sul posteriore. Un gallo, però, venne a conoscenza di questo segreto e lo rivelò ai contadini del vicinato, i quali accesero immediatamente dei falò vicino ai loro pollai: qualora la volpe si fosse avvicinata, la sua coda avrebbe sicuramente preso fuoco, causandone la morte o quantomeno la fuga. Ma la volpe, conscia del rischio che avrebbe corso con la sua “coda di paglia”, imparò a tenersi ben lontana dal fuoco.
Ci sarebbero anche altre scuole di pensiero sull’origine di questo modo di dire, più fantasiose e forse meno sostenibili.
In ogni caso, si rivela sempre molto affascinante, originale e colorita questa nostra Lingua subalpina.
Sergio Donna
Avviso ai Lettori

Questo articolo è tratto dal libro di Sergio Donna “Parlé piemontèis – Parlare piemontese” | Detti, Motti, Modi di dire e curiosità della Lingua subalpina, Ël Torèt | Monginevro Cultura. Chi fosse interessato al volume, può rivolgersi alla Redazione di Storie Piemontesi, oppure può scrivere a: segreteria@monginevrocultura.net | 011-0437207